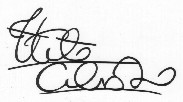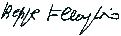L'introduzione scritta da Calvino per l’edizione del ’64 de Il sentiero dei nidi di ragno, uscito nel 1947.
La più citata, la più importante riflessione sulla letteratura del secondo dopoguerra e sul neorealismo (“neo-espressionismo”?).
Ascendenze, predilezioni letterarie, influenza e ruolo dell’esperienza sulla genesi de Il sentiero dei nidi di ragno. Un saggio splendido, un inno alla letteratura e alla vita.
Digitalizzazione del testo integrale della Prefazione a cura di Luca Diego Dominguez.
Questo romanzo è il primo che ho scritto; quasi posso dire la prima cosa che ho scritto, se si eccettuano pochi racconti. Che impressione mi fa, a riprenderlo in mano adesso? Più che come un’opera mia lo leggo come un libro nato anonimamente da un clima generale d’un’epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui la nostra generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
L’esplosione letteraria di quegli anni in Italia fu, prima che un fatto d’arte, un fatto fisiologico, esistenziale, collettivo. Avevamo vissuto la guerra, e noi più giovani – che avevamo fatto in tempo a fare il partigiano – non ce ne sentivamo schiacciati, vinti, «bruciati», ma vincitori, spinti dalla carica propulsiva della battaglia appena conclusa, depositari esclusivi d’una sua eredità. Non era facile ottimismo, però, o gratuita euforia; tutt’altro: quello di cui ci sentivamo depositari era un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero, un rovello problematico generale, anche una nostra capacità di vivere lo strazio e lo sbaraglio; ma l’accento che vi mettevamo era quello di una spavalda allegria. Molte cose nacquero da quel clima, e anche il piglio dei miei primi racconti e del mio primo romanzo.
Questo ci tocca oggi, soprattutto: la voce anonima dell’epoca, più forte delle nostre inflessioni individuali ancora incerte. L’essere usciti da un’esperienza – guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca. La rinata libertà di parlare fu per la gente al principio smania di raccontare: nei treni che riprendevano a funzionare, gremiti di persone e pacchi di farina e bidoni d’olio, ogni passeggero raccontava agli sconosciuti le vicissitudini che gli erano occorse, e così ogni avventore ai tavoli delle «mense del popolo», ogni donna nelle code ai negozi; il grigiore delle vite quotidiane sembrava cosa d’altre epoche; ci muovevamo in un multicolore universo di storie.
Chi cominciò a scrivere allora si trovò così a trattare la medesima materia dell’anonimo narratore orale: alle storie che avevamo vissuto di persona o di cui eravamo stati spettatori s’aggiungevano quelle che ci erano arrivate già come racconti, con una voce, una cadenza, un’espressione mimica. Durante la guerra partigiana le storie appena vissute si trasformavano e trasfiguravano in storie raccontate la notte attorno al fuoco, acquistavano già uno stile, un linguaggio, un umore come di bravata, una ricerca d’effetti angosciosi o truculenti. Alcuni miei racconti, alcune pagine di questo romanzo hanno all’origine questa tradizione orale appena nata, nei fatti, nel linguaggio.
Eppure, eppure, il segreto di come si scriveva allora non era soltanto in questa elementare universalità dei contenuti, non era lì la molla (forse l’aver cominciato questa prefazione rievocando uno stato d’animo collettivo, mi fa dimenticare che sto parlando di un libro, roba scritta, righe di parole sulla pagina bianca); al contrario, mai fu tanto chiaro che le storie che si raccontavano erano materiale grezzo: la carica esplosiva di libertà che animava il giovane scrittore non era tanto nella sua volontà di documentare o informare, quanto in quella di esprimere. Esprimere che cosa? Noi stessi, il sapore aspro della vita che avevamo appreso allora allora, tante cose che si credeva di sapere o di essere, e forse in quel momento sapevamo ed eravamo. Personaggi, paesaggi, spari, didascalie politiche, voci gergali, parolacce, lirismi, armi ed amplessi non erano che colori della tavolozza, note del pentagramma, sapevamo fin troppo bene che quel che contava era la musica e non il libretto, mai si videro formalisti così accaniti come quei contenutisti che eravamo, mai lirici così effusivi come quegli oggettivi che passavamo per essere.
Il «neorealismo» per noi che cominciammo di lì, fu quello; e delle sue qualità e difetti questo libro costituisce un catalogo rappresentativo, nato com’è da quella acerba volontà di far letteratura che era proprio della «scuola». Perché chi oggi ricorda il «neorealismo» soprattutto come una contaminazione o coartazione subita dalla letteratura da parte di ragioni extraletterarie, sposta i termini della questione: in realtà gli elementi extraletterari stavano lì tanto massicci e indiscutibili che parevano un dato di natura; tutto il problema ci sembrava fosse di poetica, come trasformare in opera letteraria quel mondo che per noi era il mondo.
Il «neorealismo» non fu una scuola (Cerchiamo di dire le cose con esattezza). Fu un insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, anche - o specialmente - delle Italie fino allora più inedite per la letteratura. Senza la varietà di Italie sconosciute l'una all'altra - o che si supponevano sconosciute -, senza la varietà dei dialetti e dei gerghi da far lievitare e impastare nella lingua letteraria, non ci sarebbe stato «neorealismo». Ma non fu paesano nel senso del verismo regionale ottocentesco. La caratterizzazione locale voleva dare sapore di verità a una rappresentazione in cui doveva riconoscersi tutto il vasto mondo: come la provincia americana in quegli scrittori degli Anni Trenta di cui tanti critici ci rimproveravano d'essere gli allievi diretti o indiretti. Perciò il linguaggio, lo stile, il ritmo avevano tanta importanza per noi, per questo nostro realismo che doveva essere il più possibile distante dal naturalismo. Ci eravamo fatta una linea, ossia una specie di triangolo: I Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire, ognuno sulla base del proprio lessico locale e del proprio paesaggio (Continuo a parlare al plurale, come se alludessi a un movimento organizzato e cosciente, anche ora che sto spiegando che era proprio il contrario. Come è facile, parlando di letteratura, anche nel mezzo del discorso più serio, più fondato sui fatti, passare inavvertitamente a contar storie... Per questo, i discorsi sulla letteratura mi dànno sempre più fastidio, quelli degli altri come i miei).
Il mio paesaggio era qualcosa di gelosamente mio (è di qui che potrei cominciare la prefazione: riducendo al minimo il cappello di «autobiografia d'una generazione letteraria», entrando subito a parlare di quel che mi riguarda direttamente, forse potrò evitare la genericità, l'approssimazione...), un paesaggio che nessuno aveva mai scritto davvero (Tranne Montale, - sebbene egli fosse dell'altra Riviera, Montale che mi pareva di poter leggere quasi sempre in chiave di memoria locale, nelle immagini e nel lessico). lo ero della Riviera di Ponente; dal paesaggio della mia città - San Remo - cancellavo polemicamente tutto il litorale turistico lungomare con palmizi, casinò, alberghi, ville - quasi vergognandomene; cominciavo dai vicoli della Città vecchia, risalivo per i torrenti, scansavo i geometrici campi di garofani, preferivo le «fasce» di vigna e d'oliveto coi vecchi muri a secco sconnessi, m'inoltravo per le mulattiere sopra i dossi gerbidi, fin su dove cominciano i boschi di pini, poi i castagni, e cosi ero passato dal mare - sempre visto dall'alto, una striscia tra due quinte di verde - alle valli tortuose delle Prealpi liguri.
Avevo un paesaggio. Ma per poterlo rappresentare occorreva che esso diventasse secondario rispetto a qualcos'altro: a delle persone, a delle storie. La Resistenza rappresentò la fusione tra paesaggio e persone. Il romanzo che altrimenti mai sarei riuscito a scrivere, è qui. Lo scenario quotidiano di tutta la mia vita era diventato interamente straordinario e romanzesco: una storia sola si sdipanava dai bui archivolti della Città vecchia fin su ai boschi; era l'inseguirsi e il nascondersi d'uomini armati; anche le ville, riuscivo a rappresentare, ora che le avevo viste requisite e trasformate in corpi di guardia e prigioni; anche i campi di garofani, da quando erano diventati terreni allo scoperto, pericolosi da attraversare, evocanti uno sgranare di raffiche nell'aria. Fu da questa possibilità di situare storie umane nei paesaggi che il «neorealismo»…
In questo romanzo (è meglio che riprenda il filo; per mettersi a rifare l’apologia del «neorealismo» è troppo presto; analizzare i motivi di distacco corrisponde di più al nostro stato d’animo, ancor oggi) i segni dell’epoca letteraria si confondono con quelli della giovinezza dell’autore. L’esasperazione dei motivi della violenza e del sesso finisce per apparire ingenua (oggi che il palato del lettore è abituato a trangugiare cibi ben più bollenti) e voluta (che per l’autore questi fossero motivi esterni e provvisori, lo prova il seguito della sua opera).
E altrettanto ingenua e voluta può apparire la smania di innestare la discussione ideologica nel racconto, in un racconto come questo, impostato in tutt’altra chiave: di rappresentazione immediata, oggettiva, come linguaggio e come immagini. Per soddisfare la necessità dell’innesto ideologico, io ricorsi all’espediente di concentrare le riflessioni teoriche in un capitolo che si distacca dal tono degli altri, il IX, quello delle riflessioni del commissario Kim, quasi una prefazione inserita in mezzo al romanzo. Espediente che tutti i miei primissimi lettori criticarono, consigliandomi un taglio netto del capitolo; io, pur comprendendo che l’omogeneità del libro ne soffriva (a quel tempo, l’unità stilistica era uno dei pochi criteri estetici sicuri; ancora non erano tornati in onore gli accostamenti di stili e linguaggi diversi che oggi trionfano), tenni duro: il libro era nato così, con quel tanto di composito e di spurio.
Anche l’altro grande tema futuro di discussione critica, il tema lingua-dialetto, è presente qui nella sua fase ingenua: dialetto aggrumato in macchie di colore (mentre nelle narrazioni che scriverò in seguito cercherò di assorbirlo tutto nella lingua, come un plasma vitale ma nascosto); scrittura ineguale che ora quasi s’impreziosisce ora corre giù come vien viene badando solo alla resa immediata; un repertorio documentaristico (modi di dire popolari, canzoni) che arriva quasi al folklore…
E poi (continuo l’elenco dei segni dell’età, mia e generale; una prefazione scritta ha un senso solo se è critica), il modo di figurare la persona umana: tratti esasperati e grotteschi, smorfie contorte, oscuri drammi visceral-collettivi. L’appuntamento con l’espressionismo che la cultura letteraria e figurativa italiana aveva mancato nel Primo Dopoguerra, ebbe il suo grande momento nel Secondo. Forse il vero nome per quella stagione italiana, più che «neorealismo» dovrebbe essere «neo-espressionismo».
Le deformazioni della lente espressionistica si proiettano in questo libro sui volti che erano stati dei miei cari compagni. Mi studiavo di renderli contraffatti, irriconoscibili, «negativi», perché solo nella «negatività» trovavo un senso poetico. E nello stesso tempo provavo rimorso, verso la realtà tanto più variegata e calda e indefinibile, verso le persone vere, che conoscevo come tanto umanamente più ricche e migliori, un rimorso che mi sarei portato dietro per anni…
Questo romanzo è il primo che ho scritto. Che effetto mi fa, a rileggerlo adesso (Ora ho trovato il punto: questo rimorso. E’ di qui che devo cominciare la prefazione)?. Il disagio che per tanto tempo questo libro mi ha dato in parte si è attutito, in parte resta: è il rapporto con qualcosa di tanto più grande di me, con emozioni che hanno coinvolto tutti ì miei contemporanei, e tragedie, ed eroismi, e slanci generosi e geniali, e oscuri drammi di coscienza. La Resistenza; come entra questo libro nella «letteratura della Resistenza»?
Al tempo in cui l'ho scritto, creare una «letteratura della Resistenza» era ancora un problema aperto, scrivere «il romanzo della Resistenza» si poneva come un imperativo; a due mesi appena dalla Liberazione nelle vetrine dei librai c'era già Uomini e no di Vittorini, con dentro la nostra primordiale dialettica di morte e di felicità; i «gap» di Milano avevano avuto subito il loro romanzo, tutto rapidi scatti sulla mappa concentrica della città; noi che eravamo stati partigiani di montagna avremmo voluto avere il nostro, di romanzo, con il nostro diverso ritmo, il nostro diverso andirivieni...
Non che fossi così culturalmente sprovveduto da non sapere che l'influenza della storia sulla letteratura è indiretta, lenta e spesso contraddittoria; sapevo bene che tanti grandi avvenimenti storici sono passati senza ispirare nessun grande romanzo, e questo anche durante il «secolo del romanzo» per eccellenza; sapevo che il grande romanzo del Risorgimento non è mai stato scritto... Sapevamo tutto, non eravamo ingenui a tal punto: ma credo che ogni volta che si è stati testimoni o attori d'un'epoca storica ci si sente presi da una responsabilità speciale…
A me, questa responsabilità finiva per farmi sentire il tema come troppo impegnativo e solenne per le mie forze. E allora, proprio per non lasciarmi mettere soggezione dal tema, decisi che l'avrei affrontato non di petto ma di scorcio. Tutto doveva essere visto dagli occhi d'un bambino, in un ambiente di monelli e vagabondi. Inventai una storia che restasse in margine alla guerra partigiana, ai suoi eroismi e sacrifici, ma nello stesso tempo ne rendesse il colore, l'aspro sapore, il ritmo…
Questo romanzo è il primo che ho scritto. Come posso definirlo, ora, a riesaminarlo tanti anni dopo (Devo ricominciare da capo. M’ero cacciato in una direzione sbagliata: finivo per dimostrare che questo libro era nata da un’astuzia per sfuggire all’impegno; mentre invece, al contrario…)? Posso definirlo un esempio di «letteratura impegnata» nel senso più ricco e pieno della parola. Oggi, in genere, quando si parla di «letteratura impegnata» ci se ne fa un’idea sbagliata, come d’una letteratura che serve da illustrazione a una tesi già definita a priori, indipendentemente dall’espressione poetica. Invece, quello che si chiamava l’«engagement», l’impegno, può saltar fuori a tutti i livelli; qui vuole innanzitutto essere immagini e parola, scatto, piglio, stile, spezzatura, sfida.
Già nella scelta del tema c’è un’ostentazione di spavalderia quasi provocatoria. Contro chi? Direi che volevo combattere contemporaneamente su due fronti, lanciare una sfida ai detrattori della Resistenza e nello stesso tempo ai sacerdoti d’una Resistenza agiografica ed edulcorata.
Primo fronte: a poco più d’un anno dalla Liberazione già la «rispettabilità ben pensante» era in piena riscossa, e approfittava d’ogni aspetto contingente di quell’epoca – gli sbandamenti della gioventù postbellica, la recrudescenza della delinquenza, la difficoltà di stabilire una nuova legalità – per esclamare: «Ecco, noi l’avevamo sempre detto, questi partigiani, tutti così, non ci vengano a parlare di Resistenza, sappiamo bene che razza d’ideali…». Fu in questo clima che io scrissi il mio libro, con cui intendevo paradossalmente rispondere ai benpensanti: «D’accordo, farò come se aveste ragione voi, non rappresenterò i migliori partigiani, ma i peggiori possibili, metterò al centro del mio romanzo un reparto tutto composto di tipi un po’ storti. Ebbene: cosa cambia? Anche in chi si è gettato nella lotta senza un chiaro perché, ha agito un’elementare spinta di riscatto umano, una spinta che li ha resi centomila volte migliori di voi, che li ha fatti diventare forze storiche attive quali voi non potrete mai sognarvi di essere!». Il senso di questa polemica, di questa sfida è ormai lontano: e anche allora, devo dire, il libro fu letto semplicemente come romanzo, e non come elemento di discussione su di un giudizio storico. Eppure, se ancora vi si sente frizzare quel tanto d’aria provocatoria, proviene dalla polemica d’allora.
Dalla doppia polemica. Per quanto, anche la battaglia sul secondo fronte, quello interno alla «cultura di sinistra», ora pare lontana. Cominciava appena allora il tentativo d’una «direzione politica» dell’attività letteraria: si chiedeva allo scrittore di creare l’«eroe positivo», di dare immagini normative, pedagogiche di condotta sociale, di milizia rivoluzionaria. Cominciava appena, ho detto: e devo aggiungere che neppure in seguito, qui in Italia, simili pressioni ebbero molto peso e molto seguito. Eppure, il pericolo che alla nuova letteratura fosse assegnata una funzione celebrativa e didascalica, era nell’aria: quando scrissi questo libro l’avevo appena avvertito, e già stavo a pelo ritto, a unghie sfoderate contro l’incombere d’una nuova retorica (Avevamo ancora intatta la nostra carica d’anticonformismo, allora: dote difficile da conservare, ma che – se pur conobbe qualche parziale eclisse – ancora ci sorregge, in quest’epoca tanto più facile, non meno pericolosa…). La mia reazione d’allora potrebbe essere enunciata così: «Ah, sì, volete “l’eroe socialista”? Volete il “romanticismo rivoluzionario”? E io vi scrivo una storia di partigiani in cui nessuno è eroe, nessuno ha coscienza di classe. Il mondo delle “lingère”, vi rappresento, il lunpenproletariat (Concetto nuovo, per me allora; e mi pareva una gran scoperta. Non sapevo che era stato e avrebbe continuato a essere il terreno più facile per la narrativa)! E sarà l’opera più positiva, più rivoluzionaria di tutte! Che ce ne importa di chi è già un eroe, di chi la coscienza ce l’ha già? E’ il processo per arrivarci che si deve rappresentare! Finché resterà un solo individuo al di qua della coscienza, il nostro dovere sarà di occuparci di lui e solo di lui!».
Così ragionavo, e con questa furia polemica mi buttavo a scrivere e scomponevo i tratti del viso e del carattere di persone che avevo tenuto per carissimi compagni, con cui avevo per mesi e mesi spartito la gavetta di castagne e il rischio della morte, per la cui sorte avevo trepidato, di cui avevo ammirato la noncuranza nel tagliarsi i ponti dietro le spalle, il modo di vivere sciolto da egoismi, e ne facevo maschere contratte da perpetue smorfie, macchiette grottesche, addensavo torbidi chiaroscuri – quelli che nella mia giovanile ingenuità immaginavo potessero essere torbidi chiaroscuri – sulle loro storie… Per poi provarne un rimorso che mi tenne dietro per anni…
Devo ancora ricominciare da capo la prefazione. Non ci siamo. Da quel che ho detto, parrebbe che scrivendo questo libro avessi tutto ben chiaro in testa: i motivi di polemica, gli avversari da battere, la poetica da sostenere… Invece, se tutto questo c’era, era ancora in uno stadio confuso e senza contorni. In realtà il libro veniva fuori come per caso, m’ero messo a scrivere senza avere in mente una trama precisa, partii da quel personaggio di monello, cioè da un elemento d’osservazione diretta della realtà, un modo di muoversi, di parlare, di tenere un rapporto con i grandi, e, per dargli un sostegno romanzesco, inventai la storia della sorella, della pistola rubata al tedesco; poi l’arrivo tra i partigiani si rivelò un trapasso difficile, il salto dal racconto picaresco all’epopea collettiva minacciava di mandare tutto all’aria, dovevo avere un’invenzione che mi permettesse di continuare a tenere la storia tutta sul medesimo gradino, e inventai il distaccamento del Dritto.
Era il racconto che – come sempre succede – imponeva soluzioni quasi obbligatorie. Ma in questo schema, in questo disegno che si veniva formando quasi da solo, io travasavo la mia esperienza ancora fresca, una folla di voci e volti (deformavo i volti, straziavo le persone come sempre fa chi scrive, per cui la realtà diventa creta, strumento, e sa che solo così può scrivere, eppure ne prova rimorso…), un fiume di discussioni e di letture che a quell’esperienza s’intrecciavano.
Le letture e l’esperienza di vita non sono due universi ma uno. Ogni esperienza di vita per essere interpretata chiama certe letture e si fonde con esse. Che i libri nascano sempre da altri libri è una verità solo apparentemente in contraddizione con l’altra: che i libri nascano dalla vita pratica e dai rapporti tra gli uomini Appena finito di fare il partigiano trovammo (prima in pezzi sparsi per riviste, poi tutto intero) un romanzo sulla guerra di Spagna che Hemingway aveva scritto sei o sette anni prima: Per chi suona la campana. Fu il primo libro in cui ci riconoscemmo: fu di lì che cominciammo a trasformare in motivi narrativi e frasi quello che avevamo visto sentito e vissuto, il distaccamento di Pablo e di Pilar era il «nostro» distaccamento. (Ora magari quello è il libro di Hemingway che ci piace di meno; anzi, già a quei tempi, fu scoprendo in altri libri dello scrittore americano – particolarmente nei suoi primi racconti – la vera sua lezione di stile, che Hemingway divenne il nostro autore).
La letteratura che ci interessava era quella che portava questo senso d’umanità ribollente e di spietatezza e di natura: anche i russi del tempo della Guerra civile – cioè di prima che la letteratura sovietica diventasse castigata e oleografica – li sentivamo come nostri contemporanei. Soprattutto Babel, del quale conoscevamo L’armata a cavallo, tradotto in Italia già prima della guerra, uno dei libri esemplari del realismo del nostro secolo, nato dal rapporto tra l’intellettuale e la violenza rivoluzionaria.
Ma anche – su un livello minore – Fadeev (prima di diventare un funzionario della letteratura sovietica ufficiale), il suo primo libro, La disfatta, l’aveva scritto con quella sincerità e quel vigore (non ricordo se l’avessi già letto quando scrissi il mio libro, e non vado a verificare, non è quello che importa, da situazioni simili nascono libri che si somigliano, come struttura e come spirito); Fadeev che seppe finire bene come aveva cominciato, perché fu il solo scrittore staliniano, nel ’56, a dimostrare d’aver capito fino in fondo la tragedia di cui era stato corresponsabile (la tragedia in cui Babel e tanti altri scrittori veri della Rivoluzione avevano perso la vita), e a non tentare ipocrite recriminazioni, ma a trarne la conseguenza più severa: un colpo di pistola in fonte.
Questa letteratura c’è dietro al Sentiero dei nidi di ragno. Ma in gioventù ogni libro nuovo che si legge è come un nuovo occhio che si apre e modifica la vista degli altri occhi o libri-occhi che si avevano prima, e della nuova idea di letteratura che smaniavo di fare rivivevano tutti gli universi letterari che m’avevano incantato dal tempo dell’infanzia in poi… Cosicché, mettendomi a scrivere qualcosa come Per chi suona la campana di Hemingway volevo insieme scrivere qualcosa come L’isola del tesoro di Stevenson.
Chi lo capì subito fu Cesare Pavese, che indovinò dal Sentiero tutte le mie predilezioni letterarie. Nominò anche Nievo, a cui avevo voluto dedicare un segreto omaggio ricalcando l’incontro di Pin con Cugino sull’incontro di Carlino con lo Spaccafumo nelle Confessioni d’un Italiano.
Fu Pavese il primo a parlare di tono fiabesco a mio proposito, e io, che fino ad allora non me n’ero reso conto, da quel momento in poi lo seppi fin troppo, e cercai di confermare la definizione. La mia storia cominciava a esser segnata, e ora mi pare tutta contenuta in quell’inizio.
Forse, in fondo, il primo libro è il solo che conta, forse bisognerebbe scrivere quello e basta, il grande strappo lo dài solo in quel momento, l’occasione di esprimerti si presenta solo una volta, il nodo che porti dentro o lo sciogli quella volta o mai più. Forse la poesia è possibile solo in un momento della vita che per i più coincide con l’estrema giovinezza. Passato quel momento, che tu ti sia espresso o no (e non lo saprai se non dopo cento, centocinquant’anni; i contemporanei non possono essere buoni giudici), di lì in poi i giochi son fatti, non tornerai che a fare il verso agli altri o a te stesso, non riuscirai più a dire una parola vera, insostituibile…
Interrompo. Ogni discorso basato su una pura ragione letteraria, se è veritiero, finisce in questo scacco, in questo fallimento che è sempre lo scrivere. Per fortuna scrivere non è solo un fatto letterario, ma anche altro. Ancora una volta, sento il bisogno di correggere la piega presa dalla prefazione.
Questo altro, nelle mie preoccupazioni d’allora, era una definizione di cos’era stata la guerra partigiana. Con un mio amico e coetaneo, che ora fa il medico, e allora era studente come me, passavamo le sere a discutere. Per entrambi la Resistenza era stata l’esperienza fondamentale; per lui in maniera molto più impegnative perché s’era trovato ad assumere responsabilità serie, e a poco più di vent’anni era stato commissario d’una divisione partigiana, quella di cui io pure avevo fatto parte come semplice garibaldino. Ci pareva, allora, a pochi mesi dalla Liberazione, che tutti parlassero della Resistenza in modo sbagliato, che una retorica che s’andava creando ne nascondesse la vera essenza, il suo carattere primario. Mi sarebbe difficile ora ricostruire quelle discussioni; ricordo solo la continua nostra polemica contro tutte le immagini mitizzate, la nostra riduzione della coscienza partigiana a un quid elementare, quello che avevamo conosciuto nei più semplici dei nostri compagni, e che diventava la chiave della storia presente e futura.
Il mio amico era un argomentatore analitico, freddo, sarcastico verso ogni cosa che non fosse un fatto; l’unico personaggio intellettuale di questo libro, il commissario Kim, voleva essere un suo ritratto; e qualcosa delle nostre discussioni d’allora, nella problematica del perché combattevano quegli uomini senza divisa né bandiera, dev’essere rimasta nelle mie pagine, nei dialoghi di Kim col comandante di brigata e nei suoi soliloqui.
L’entroterra del libro erano queste discussioni, e più indietro ancora, tutte le mie riflessioni sulla violenza, da quando m’ero trovato a prendere le armi. Ero stato, prima d’andare coi partigiani, un giovane borghese sempre vissuto in famiglia; il mio tranquillo antifascismo era prima di tutto opposizione al culto della forza guerresca, una questione di stile, di «sense of humour», e tutt’a un tratto la coerenza con le mie opinioni mi portava in mezzo alla violenza partigiana, a misurarmi su quel metro. Fu un trauma, il primo…
E contemporaneamente, le riflessioni sul giudizio morale verso le persone e sul senso storico delle azioni di ciascuno di noi. Per molti dei miei coetanei, era stato solo il caso a decidere da che parte dovessero combattere; per molti le parti tutt’a un tratto si invertivano, da repubblichini diventavano partigiani o viceversa; da una parte o dall’altra sparavano o si facevano sparare; solo la morte dava alle loro scelte un segno irrevocabile (Fu Pavese che riuscì a scrivere: «Ogni caduto somiglia a chi resta, e gliene chiede ragione», nelle ultime pagine della Casa in collina, strette tra il rimorso di non aver combattuto e lo sforzo d’essere sincero sulle ragioni del suo rifiuto).
Ecco: ho trovato come devo impostare la prefazione. Per mesi, dopo la fine della guerra, avevo provato a raccontare l’esperienza partigiana in prima persona, o con un protagonista simile a me. Scrissi qualche racconto che pubblicai, altri che buttai nel cestino; mi muovevo a disagio; non riuscivo mai a smorzare del tutto le vibrazioni sentimentali e moralistiche; veniva fuori sempre qualche stonatura; la mia storia personale mi pareva umile, meschina; ero pieno di complessi, d’inibizioni di fronte a tutto quel che più mi stava a cuore.
Quando cominciai a scrivere storie in cui non entravo io, tutto prese a funzionare: il linguaggio, il ritmo, il taglio erano esatti, funzionali; più lo facevo oggettivo, anonimo, più il racconto mi dava soddisfazione; e non solo a me, ma anche quando lo facevo leggere alla gente del mestiere che ero andato conoscendo in quei primi tempi postbellici, - Vittoriani e Ferrata a Milano, Natalia e Pavese a Torino, - non mi facevano più osservazioni. Cominciai a capire che un racconto, quanto più era oggettivo e anonimo, tanto più era mio.
Il dono di scrivere «oggettivo» mi pareva allora la cosa più naturale del mondo; non avrei mai immaginato che così presto l’avrei perduto. Ogni storia si muoveva con perfetta sicurezza in un mondo che conoscevo così bene: era questa la mia esperienza, la mia esperienza moltiplicata per le esperienze degli altri. E il senso storico, la morale, il sentimento, erano presenti proprio perché li lasciavo impliciti, nascosti.
Quando cominciai a sviluppare un racconto sul personaggio d’un ragazzetto partigiano che avevo conosciuto nelle bande, non pensavo che m’avrebbe preso più spazio degli altri. Perché si trasformò in un romanzo? Perché – compresi poi – l’identificazione tra me e il protagonista era diventata qualcosa di più complesso. Il rapporto del personaggio del bambino Pin e la guerra partigiana corrispondeva simbolicamente al rapporto che con la guerra partigiana m’ero trovato ad avere io. L’inferiorità di Pin come bambino di fronte all’incomprensibile mondo dei grandi corrisponde a quella che nella stessa situazione provavo io, come borghese. E la spregiudicatezza di Pin, per via della tanto vantata sua provenienza dal mondo della malavita, che lo fa sentire complice quasi superiore verso ogni «fuori-legge», corrisponde al modo «intellettuale» d’essere all’altezza della situazione, di non meravigliarsi mai, di difendersi dalle emozioni… Così, data questa chiave di trasposizioni – ma fu solo una chiave a posteriori, sia ben chiaro, che mi servì in seguito a spiegarmi cos’avevo scritto – la storia in cui il mio punto di vista personale era bandito ritornava ad essere la mia storia…
La mia storia era quella dell’adolescenza durata troppo a lungo, per il giovane che aveva preso la guerra come un alibi, nel senso proprio e in quello traslato. Nel giro di pochi anni, d’improvviso l’alibi era diventato un qui e ora. Troppo presto, per me; o troppo tardi: i sogni sognati troppo a lungo, io ero impreparato a viverli. Prima, il capovolgersi della guerra estranea, il trasformarsi in eroi e in capi degli oscuri e refrattari di ieri. Ora, nella pace, il fervore delle nuove energie che animava tutte le relazioni, che invadeva tutti gli strumenti della vita pubblica, ed ecco anche il lontano castello della letteratura s’apriva come un porto vicino e amico, pronto ad accogliere il giovane provinciale con fanfare e bandiere. E una carica amorosa elettrizzava l’aria, illuminava gli occhi delle ragazze che la guerra e la pace ci avevano restituito e fatto più vicine, divenute ora davvero coetanee e compagne, in un’intesa che era il nuovo regalo di quei primi mesi di pace, a riempire di dialoghi e di risa le calde sere dell’Italia resuscitata.
Di fronte a ogni possibilità che s’apriva, io non riuscivo a essere quello che avevo sognato prima dell’ora della prova: ero stato l’ultimo dei partigiani; ero un innamorato incerto e insoddisfatto e inabile; la letteratura non mi s’apriva come un disinvolto e distaccato magistero ma come una strada in cui non sapevo da che parte cominciare. Carico di volontà e tensione giovanili, m’era negata la spontanea grazia della giovinezza. Il maturare impetuoso dei tempi non aveva fatto che accentuare la mia immaturità.
Il protagonista simbolico del mio libro fu dunque un’immagine di regressione: un bambino. Allo sguardo infantile e geloso di Pin, armi e donne ritornavano lontane e incomprensibili; quel che la mia filosofia esaltava, la mia poetica trasfigurava in apparizioni nemiche, il mio eccesso d’amore tingeva di disperazione infernale.
Scrivendo, il mio bisogno stilistico era tenermi più in basso dei fatti, l’italiano che mi piaceva era quello di chi «non parla l’italiano a casa», cercavo di scrivere come avrebbe scritto un ipotetico me stesso autodidatta.
Il sentiero dei nidi di ragno è nato da questo senso di nullatenenza assoluta, per metà patita fino allo strazio, per metà supposta e ostentata. Se un valore oggi riconosco a questo libro è lì: l’immagine d’una forza vitale ancora oscura in cui si saldano l’indigenza del «troppo giovane» e l’indigenza degli esclusi e dei reietti.
Se dico che allora facevamo letteratura del nostro stato di povertà, non parlo tanto d’una programmaticità ideologica, quanto di qualcosa di più profondo che era in ciascuno di noi.
Oggi che scrivere è una professione regolare, che il romanzo è un «prodotto», con un suo «mercato», una sua «domanda» e una sua «offerta», con le sue campagne di lancio, i suoi successi e i suoi tran-tran, ora che i romanzi italiani sono tutti «di un buon livello medio» e fanno parte della quantità di beni superflui di una società troppo presto soddisfatta, è difficile richiamarci alla mente lo spirito con cui tentavamo di cominciare una narrativa che aveva ancora da costruirsi tutto con le proprie mani.
Continuo a usare il plurale, ma vi ho già spiegato che parlo di qualcosa di sparso, di non concordato, che usciva da angoli di provincia diversi, senza ragioni esplicite in comune che non fossero parziali e provvisorie. Fu più che altro – diciamo – una potenzialità diffusa nell’aria. E presto spenta.
Già negli Anni Cinquanta il quadro era cambiato, a cominciare dai maestri: Pavese morto, Vittoriani chiuso in un silenzio d’opposizione, Moravia che in un contesto diverso veniva acquistando un altro significato (non più esistenziale ma naturalistico) e il romanzo italiano prendeva il suo corso elegiaco-moderato-sociologico in cui tutti finimmo per scavarci una nicchia più o meno comoda (o per trovare le nostre scappatoie).
Ma ci fu chi continuò sulla via di quella prima frammentaria epopea: in genere furono i più isolati, i meno «inseriti» a conservare questa forza. E fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se l’aspettava, Beppe Fenoglio, e arrivò a scriverlo e nemmeno finirlo (Una questione privata), e morì prima di vederlo pubblicato, nel pieno dei quarant’anni. Il libro che la nostra generazione voleva fare, adesso c’è, e il nostro lavoro ha un coronamento e un senso, e solo ora, grazie a Fenoglio, possiamo dire che una stagione è compiuta, solo ora siamo certi che è veramente esistita: la stagione che va dal Sentiero dei nidi di ragno a Una questione privata.
Una questione privata (che ora si legge nel volume postumo di Fenoglio Un giorno di fuoco) è costruito con la geometrica tensione d’un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come l’Orlando furioso, e nello stesso tempo c'è la Resistenza proprio com’era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele, e con tutti i valori morali, tanto più forti quanto più impliciti, e la commozione, e la furia. Ed è un libro di paesaggi, ed è un libro di figure rapide e tutte vive, ed è un libro di parole precise e vere. Ed è un libro assurdo, misterioso, in cui ciò che si insegue, si insegue per inseguire altro, e quest'altro per inseguire altro ancora e non si arriva al vero perchè.
E’ al libro di Fenoglio che volevo fare la prefazione: non al mio.
Questo romanzo è il primo che ho scritto, quasi la prima cosa che ho scritto. Cosa ne posso dire, oggi? Dirò questo: il primo libro sarebbe meglio non averlo mai scritto.
Finché il primo libro non è scritto, si possiede quella libertà di cominciare che si può usare una sola volta nella vita, il primo libro già ti definisce mentre tu in realtà sei ancora lontano dall’esser definito; e questa definizione poi dovrai portartela dietro per la vita, cercando di darne conferma o approfondimento o correzione o smentita, ma mai più riuscendo a prescinderne.
E ancora: per coloro che da giovani cominciarono a scrivere dopo un’esperienza di quelle con «tante cose da raccontare» (la guerra, in questo e in molti altri casi), il primo libro diventa subito un diaframma tra te e l’esperienza, taglia i fili che ti legano ai fatti, brucia il tesoro di memoria – quello che sarebbe diventato un tesoro se avessi avuto la pazienza di custodirlo, se non avessi avuto tanta fretta di spenderlo, di scialacquarlo, d’imporre una gerarchia arbitraria tra le immagini che avevi immagazzinato, di separare le privilegiate, presunte depositarie d’una emozione poetica, dalle altre, quelle che sembravano riguardarti troppo o troppo poco per poterle rappresentare, insomma d’istituire di prepotenza un’altra memoria, una memoria trasfigurata al posto della memoria globale coi suoi confini sfumati, con la sua infinita possibilità di recuperi… Di questa violenza che le hai fatto scrivendo, la memoria non si riavrà più: le immagini privilegiate resteranno bruciate dalla precoce promozione a motivi letterari, mentre le immagini che hai voluto tenere in serbo, magari con la segreta intenzione di servirtene in opere future, deperiranno, perché tagliate fuori dall’integrità naturale della memoria fluida e vivente. La proiezione letteraria dove tutto è solido e fissato una volta per tutte, ha ormai occupato il campo, ha fatto sbiadire, ha schiacciato la vegetazione dei ricordi in cui la vita dell’albero e quella del filo d’erba si condizionano a vicenda. La memoria – o meglio l’esperienza, che è la memoria più la ferita che ti ha lasciato, più il cambiamento che ha portato in te e che ti ha fatto diverso -, l’esperienza primo nutrimento anche dell’opera letteraria (ma non solo di quella), ricchezza vera dello scrittore (ma non solo di lui), ecco che appena ha dato forma a un’opera letteraria insecchisce, si distrugge. Lo scrittore si ritrova ad essere il più povero degli uomini.
Così mi guardo indietro, a quella stagione che mi si presentò gremita d’immagini e di significati: la guerra partigiana, i mesi che hanno contato per anni e da cui per tutta la vita si dovrebbe poter continuare a tirar fuori volti e ammonimenti e paesaggi e pensieri ed episodi e parole e commozioni: e tutto è lontano e nebbioso, e le pagine scritte sono lì nella loro sfacciata sicurezza che so bene ingannevole, le pagine scritte già in polemica con una memoria che era ancora un fatto presente, massiccio, che pareva stabile, dato una volta per tutte, l’esperienza, - e non mi servono, avrei bisogno di tutto il resto, proprio di quello che lì non c’è. Un libro scritto non mi consolerà mai di ciò che ho distrutto scrivendolo: quell’esperienza che custodita per gli anni della vita mi sarebbe forse servita a scrivere l’ultimo libro, e non mi è bastata che a scrivere il primo.
Giugno 1964 I.C.